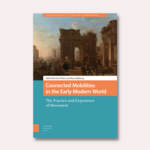Descrizione
Chi siete e da dove venite?
M. Sono Massimo Rospocher , nato e cresciuto a Trento, anche se la mia famiglia di mio padre -come tradisce il cognome- è originaria di Calliano.
R. Sono Rosa Salzberg , nata a Melbourne, in Australia, anche se discendo da entrambi i lati da europei emigrati in Australia nel XIX e XX secolo.
Rosa, quali studi e quale percorso formativo hai fatto?
Ho studiato all'Università di Melbourne prima di trasferirmi a Londra per conseguire il dottorato in Storia del Rinascimento italiano al Queen Mary College, Università di Londra. Questo mi ha portata a fare ricerca in Italia, soprattutto a Venezia. Mi sono innamorata dell'Italia quando ho viaggiato qui come backpacker (zaino in spalla, ndr) a 19 anni e ho studiato la lingua per qualche settimana a Firenze. Poi ho continuato a studiare la storia e la lingua e non mi sono più voltata indietro.
Massimo, quali studi e quale percorso formativo hai sostenuto?
Ho frequentato il Liceo Scientifico Galileo Galilei e mi sono laureato in Lettere Moderne all’Università di Trento. Mi sono poi trasferito a Firenze per un master e un dottorato presso la European University Institute (EUI) , una scuola di formazione post-universitaria finanziata dalla comunità europea. Un’istituzione di ricerca realmente internazionale, multiculturale e plurilingue che abbiamo la fortuna di avere in Italia e che forse è poco conosciuta o valorizzata. A me personalmente ha aperto molte strade e opportunità.
Dove vi siete incontrati e in quale occasione? Vi va di raccontarci com’è è andata?
M. Ci siamo incontrati a un convegno internazionale di storia del Rinascimento a Chicago. Nel 2007, mi pare. Possiamo dire che era destino, dal momento che eravamo allora quasi gli unici a occuparci di figure marginali del Rinascimento italiano, come cantastorie o intrattenitori di piazza, oppure di oggetti all'apparenza minori come le stampe popolari e i fogli volanti venduti nelle strade dagli ambulanti. Un soggetto, potremmo dire, piuttosto di nicchia e poco studiato dagli storici.
R. Ci siamo rivisti qualche mese dopo a Firenze dove stavo svolgendo un periodo di studio post-dottorale presso l'Istituto Universitario Europeo. Scherzando, prima di conoscerlo di persona, dicevo ai miei coinquilini che Massimo era l'unico uomo al mondo che non avrei mai potuto sposare, perché i nostri interessi di ricerca erano talmente sovrapponibili che pensavo non avremmo mai trovato lavoro nello stesso posto. Poi invece l'ho incontrato e “the rest is history”…
Per anni avete vissuto in UK, cosa facevate? Eravate stabili in Inghilterra?
R. Nel 2010 ho assunto un incarico di docenza presso l'Università di Warwick nel Regno Unito e nel 2011 Massimo ha iniziato una posizione di ricerca presso l'Università di Leeds, così almeno abbiamo potuto risiedere nello stesso Paese. Abbiamo trascorso alcuni anni molto belli vivendo a Leamington Spa, una cittadina termale e universitaria vicino a Birmingham, ed esplorando insieme il Regno Unito.
M. Ho ricordi molto belli dell’esperienza inglese, non solo per il lavoro, ma anche per le amicizie internazionali che sono maturate in quegli anni. La campagna era una delle nostre mete preferite, ma abbiamo ammirato anche la bellezza della costa, soprattutto del Galles. Inoltre, la nostra prima figlia, Mila, è nata lì, a Warwick.
La Brexit, però, ha un po’ appannato questo ricordo e tutto sommato non siamo pentiti della scelta di lasciare l’Inghilterra.
Non vi piace la definizione di "cervelli in fuga”, perché? Che riflessioni avete fatto a riguardo, la vedete tutti e due allo stesso modo, o c’è qualche differenza nel vostro sguardo?
M. Credo che la retorica dei “cervelli in fuga” sia eminentemente italiana. Risponde infatti a un problema reale ed endemico, che è l’incapacità del sistema della ricerca di offrire delle opportunità agli studiosi formati in Italia di sviluppare il patrimonio di conoscenze acquisito. La questione viene spesso presentata come una sorta di investimento non messo a frutto, come perdita di un capitale umano.
In realtà, secondo me, il problema è un altro. Andare all’estero non equivale sempre a una ‘fuga’. Anzi, spesso è una forma di ulteriore arricchimento per chi fa ricerca, si dovrebbe però riuscire a garantire la possibilità -a chi vuole- di ritornare e magari di attirare anche studiosi dall’estero. D’altronde, una delle ricchezze dell’Europa dovrebbe essere anche la libera mobilità delle persone e delle idee, oltre che delle merci e dei commerci. Purtroppo, per l’Italia il saldo tra ricercatori in entrata (cioè educati all’estero) e quelli in uscita rimane negativo.
R. Sono d'accordo con Massimo. Avere l'esperienza di lavorare all'estero è stato un enorme vantaggio per lui, ma è anche bello che sia stato in grado di portare questa esperienza in Italia. Dal mio punto di vista, sono felice che le università italiane stiano diventando più aperte a reclutare personale dall'estero, come nel mio caso - una sorta di "ingresso dei cervelli" che penso possa solo giovare al sistema accademico italiano, come è avvenuto in altri paesi. Come il Regno Unito, prima della Brexit almeno.
Tutto questo tempo passato all’estero in cosa vi ha cambiati?
R. Ormai ho trascorso la maggior parte della mia vita adulta lontano dall'Australia, anche se mi manca ancora, soprattutto la mia famiglia e i miei amici. Ma questo mi ha permesso di seguire le mie passioni e i miei interessi (la storia europea) e di fare esperienze professionali che non avrei mai fatto se fossi rimasta in Australia. Gli ultimi anni, con la pandemia, hanno però cambiato il mio modo di pensare: le distanze mi sono sembrate improvvisamente molto più grandi e non ho più avuto la libertà di tornare a casa e visitare quando volevo. Anche i miei genitori stanno invecchiando e questo rende difficile la lontananza. Allo stesso tempo, il fatto di avere le nostre figlie qui, e ora una casa e un ottimo lavoro, mi fa sentire più stabile e più come se questa fosse "casa". Queste esperienze personali mi hanno anche portato a studiare la storia della migrazione e ad essere affascinata dal modo in cui le persone affrontano l'abbandono delle loro case e la creazione di nuove in un luogo diverso, anche se di solito in circostanze molto più difficili delle mie.
M. Oltre all’Inghilterra, ho avuto la possibilità di lavorare per periodi più brevi anche in Canada, Australia e USA. Dal punto di vista professionale, sicuramente l’aver conosciuto ambienti e culture accademiche -ma non solo- così differenti mi ha garantito un’apertura, una curiosità intellettuale e un’adattabilità a situazioni diverse che prima non avevo.
Pur nelle difficoltà di dover gestire e dover trovare un punto d’equilibrio nella vita familiare, c’è da dire che la nostra rimane un’esperienza di emigrazione di una categoria privilegiata, alla ricerca delle migliori opportunità professionali.
Ora dove vivete e cosa fate? Siete sposati? Avete figli?
M. & R. Siamo sposati da quasi 11 anni e abbiamo due figlie di 4 e 8 anni, Lea e Mila. Viviamo a Calliano. Entrambi abbiamo avuto la fortuna di trovare un ottimo lavoro, facendo ciò che amiamo, nella stessa città, cosa che non avremmo mai pensato fosse possibile e che rappresenta una fortuna rara nelle coppie accademiche.
Cosa vi ha fatto decidere di venire a vivere in Trentino?
R. Siamo tornati a vivere qui nel 2015, perché Massimo doveva rientrare al suo posto di lavoro alla Fondazione Bruno Kessler e fortunatamente ero in maternità e sono potuta venire anch'io. All'inizio pensavamo che potesse essere un trasferimento temporaneo, ma alla fine sono riuscita a trovare lavoro qui all'Università di Trento e, poiché lo troviamo un posto ideale dove vivere, soprattutto con le bambine, siamo felici di rimanere qui.
M. Devo ammettere che dopo aver lasciato il Trentino, non avrei mai pensato di tornare a vivere qui. Per diversi anni non riuscivo a fermarmi qui più di qualche settimana e mi sono goduto viaggi in paesi e continenti diversi.
Dopo la nascita della nostra prima figlia in Inghilterra, si è manifestata la necessità di trovare una base comune per la famiglia e ci è sembrato il luogo ideale. Ora non vorrei esagerare con l’idea del Trentino come un’idilliaca isola felice, i problemi esistono anche qui, ma le esperienze altrove mi permettono di dire che la qualità della vita rimane molto alta rispetto ad altri contesti in Italia, ma non solo.
È difficile relazionarsi e stare con la gente trentina? Quali persone vedete solitamente fuori dal lavoro?
M. Diciamo che conoscevo il genere, per cui lascio senz’altro la parola a Rosa.
R. È stato sicuramente un grande cambiamento per me, dato che non avevo mai vissuto in un paese così piccolo come Calliano e non avevo mai soggiornato in Italia per più di sei mesi. Ma ho imparato ad apprezzare i vantaggi di vivere in un posto più piccolo e di avere molti aspetti della nostra vita a portata di mano. Inoltre, venendo da un continente in cui le distanze sono immense, mi sorprende sempre come il luogo dove viviamo sia vicino a Trento e Rovereto e a non più di qualche ora di treno da molte altre grandi città italiane ed europee. Poi siamo fortunati ad avere la famiglia di Massimo nelle vicinanze e un meraviglioso gruppo di amici che, nel corso del tempo, hanno iniziato a sentirsi come quasi una seconda famiglia per me.
Rosa, come ti trovi in Trentino? cosa ti dà questa terra e/o non dà? Hai o avete progetti in mente per il futuro?
R. Non ero mai stata in Trentino prima di conoscere Massimo, ma ho imparato ad amarlo. Apprezzo la natura e la qualità della vita qui, e mi piace molto il mio lavoro all'università. Mi manca un po' la diversità e il multiculturalismo delle grandi città in cui vivevo prima. Ma alla fine è il posto in cui siamo riusciti a trovare una situazione che funziona bene per tutti noi e quella è incredibilmente preziosa. Per il momento siamo felici di avere questa come base, anche se il sogno sarebbe quello di trascorrere un giorno più tempo anche in Australia!
Mi sono anche interessata sempre di più alla storia di questa regione, come da secoli luogo di transito tra diverse parti d'Europa ma anche come regione di confine con una storia e un'identità ricche e complesse. Quando posso, mi piace portare i miei studenti fuori dall'aula per passeggiare in città e conoscere la sua storia insieme a me.
M. Penso che in futuro, per le nostre figlie, sarà importante mantenere vivo anche il loro senso di appartenenza nei confronti dell’Australia, un’appartenenza che si manifesta nel loro bilinguismo. Pur crescendo in Trentino, cercheremo di consolidare il più possibile questa parte della loro identità e le loro radici che affondano in un altro continente.
Per approfondire le pubblicazioni di Rosa e Massimo clicca qui
Per maggiori informazioni sull'attività di ricerca di Rosa Salzberg clicca qui